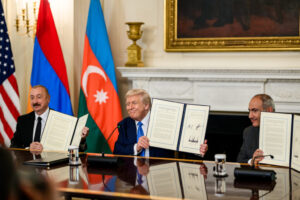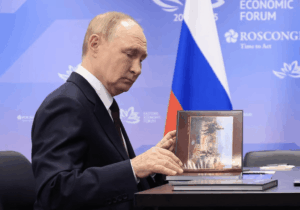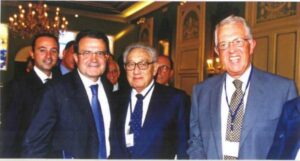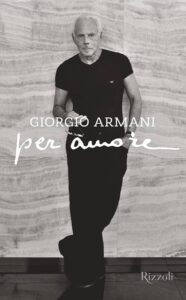Ahmad Hussein al-Shara, alias Abu Mohammed al-Jolani, vorrebbe che si pensasse che fosse un uomo cambiato. In questi giorni, al-Jolani, un agente di 41 anni di al-Qaeda e Stato Islamico con una taglia di 10 milioni di dollari sulla testa, non vomita più fuoco e zolfo jihadisti. Invece, predica il pluralismo, la tolleranza religiosa, la diversità e il perdono mentre i suoi ribelli di Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) prendono il controllo di Damasco, la capitale siriana.
Con la caduta del Presidente Bashar al-Assad per Mosca, in Russia, la presa di 54 anni dell’intera famiglia Assad sulla Siria è giunta al termine. Ora molti nel Paese e nella comunità internazionale chiedono quale sia il vero al-Jolani.
In una recente intervista, al-Jolani, il volto dei ribelli siriani, ha insistito sul fatto che la sua evoluzione era naturale. “Una persona ventenne avrà una personalità diversa da quella di qualcuno di trent’anni o quarenta, e certamente qualcuno di cinquant’anni. Questa è la natura umana”, ha detto al-Jolani.
Il vero al-Jolani probabilmente emergerà nel modo in cui si avvicina alla formazione di un governo di transizione post-Assad, nonché ai diritti, alla sicurezza e alla protezione delle minoranze. Questi includono gli alawiti musulmani sciiti da cui provengono gli Assad e che hanno a lungo sostenuto il loro governo brutale.
Inoltre, anche coloro che mettono in dubbio la sincerità della sua conversione suggeriscono che al-Jolani potrebbe essere l’unico comandante ribelle che può tenere insieme la Siria. “Non c’è potere militare locale per resistere o competere con Jolani”, ha detto un socio del leader ribelle quando si identificava ancora pubblicamente come jihadista. L’ex socio ha avvertito che se al-Jolani fallisce, la Siria, come la Libia, diventerà uno stato distranato da milizie armate rivali.
Al-Jolani “non è cambiato affatto, ma c’è una differenza tra essere in battaglia, in guerra, uccidere e gestire un paese”, ha detto l’ex socio. Ha suggerito che la posizione più moderata e conciliante del leader ribelle derivava dal riconoscimento che la sete di sangue settaria dello Stato Islamico era un errore. Ha anche dichiarato che al-Jolani “ora si considera uno statista” e ha affermato che il leader ribelle potrebbe seguire i suggerimenti di trasformare il gruppo in un partito politico trasferendo la sua ala militare a un esercito siriano ricostituito.
Nel frattempo, il gruppo paramilitare HTS si è mosso rapidamente per salvaguardare gli edifici pubblici a Damasco e gestire la presenza di fazioni pesantemente armate nella capitale. “Presto vieteremo raduni di persone armate”, ha detto Amer al-Sheikh, un funzionario della sicurezza dell’HTS.
Al-Jolani ha bisogno di guadagnare fiducia internazionale
Il 10 dicembre 2024, i ribelli hanno nominato Mohammed al-Bashir primo ministro ad interim per quattro mesi. Non era immediatamente chiaro quale sarebbe stato il passo successivo.
Al-Bashir gestiva il governo della Salvezza guidato dai ribelli nella loro roccaforte nella regione settentrionale di Idlib in Siria. Da quando HTS ha lanciato la sua offensiva, ha assistito le città catturate, tra cui Aleppo, Hama e Homs, nell’installazione di strutture di governance post-Assad.
Oltre a garantire la sicurezza interna e la stabilità, al-Jolani dovrà garantire il sostegno internazionale per la ricostruzione e la riabilitazione della Siria traumatizzata e devastata dalla guerra. Per farlo, al-Jolani e HTS dovranno convincere le minoranze siriane, i segmenti dei musulmani sunniti della maggioranza siriana e la comunità internazionale che hanno genuinamente cambiato i loro colori e non sono lupi travestiti da pecora.
Un record discutibile dei diritti umani che è persistito molto tempo dopo che hanno sconfessato il jihadismo aggrava i problemi di reputazione di HTS e al-Jolani. Non più tardi nell’agosto 2024, le Nazioni Unite hanno accusato il gruppo di ricorrere a uccisioni extragiudiziali, torture e reclutamento di bambini soldato.
“HTS ha detenuto uomini, donne e bambini di sette anni. Includevano civili detenuti per aver criticato l’HTS e aver partecipato a manifestazioni “, ha detto il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite in un rapporto. “Questi atti possono equivalere a crimini di guerra”.
Anche così, questa settimana, l’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria Geir Pedersen ha riconosciuto che HTS ha cercato di affrontare le preoccupazioni negli ultimi giorni.
“La realtà finora è che l’HTS e anche gli altri gruppi armati hanno inviato buoni messaggi al popolo siriano”, ha detto Pedersen. “Hanno inviato messaggi di unità, di inclusività… Abbiamo anche visto… cose rassicuranti sul campo”.
Pedersen si riferiva alle assicurazioni ribelli date alle minoranze, all’impegno a non imporre restrizioni sull’abbigliamento femminile, all’amnistia per il personale di arruolo dell’esercito di Assad, ai ribelli che raggiungono i funzionari governativi di Assad e agli sforzi per salvaguardare le istituzioni governative.
I funzionari degli Stati Uniti hanno fatto eco a Pedersen nonostante la designazione statunitense di HTS come organizzazione terroristica.
Incidenti a Damasco e Hama
Sullo sfondo del suo curriculum negli ultimi anni nell’amministrazione della regione di Idlib, l’ultima roccaforte ribelle in Siria quando le linee di battaglia della guerra civile erano congelate nel 2020, al-Jolani ha cercato di proiettare un’immagine di tolleranza, riconciliazione e capacità di fornire beni e servizi pubblici.
Al-Jolani trasformò Idlib, storicamente la provincia più povera del paese, nella sua regione in più rapida crescita, nonostante il suo dominio autocratico e i frequenti attacchi aerei siriani e russi. A suo merito, non ci sono state importanti segnalazioni di attacchi contro cristiani, alawiti e altre minoranze o atti di vendetta contro i rappresentanti del regime di Assad, compresi i militari. Inoltre, non c’è stato alcun sacco di massa mentre i combattenti dell’HTS hanno preso il controllo di città e paesi, tra cui Damasco.
Questo non vuol dire che tutto si sia svolto senza incidenti. Un residente di Damasco ha riferito che uomini armati non identificati avevano bussato alla porta di un conoscente e chiesto della sua religione. Un vicino è tornato a casa per trovare la sua porta rotta e il suo appartamento sacconnato. Allo stesso modo, un edificio governativo vicino è stato saccheggiato nonostante le istruzioni dei leader ribelli contro la violazione della proprietà pubblica. I ribelli hanno imposto un coprifuoco notturno a Damasco per mantenere la legge e l’ordine.
In precedenza, un uomo di Hama ha detto ai prigionieri seduti a terra con le mani legate dietro di loro in un video sui social media: “Guariremo i cuori dei credenti tagliandovi la testa, maiali”.
La dichiarazione di HTS sulle armi chimiche siriane
Nel frattempo, con Israele che bombarda gli arsenali siriani di armi strategiche, compresi i siti di armi chimiche sospette, l’HTS ha perso un’opportunità di raccogliere inequivocabilmente la fiducia. In una dichiarazione, il gruppo ha detto che salvaguarderà le restanti scorte di armi chimiche del paese e garantirà che non siano utilizzate contro i cittadini. Questo è un netto contrasto con il regime di Assad, che ha usato armi chimiche in diverse occasioni contro i civili siriani.
Sulla scia della caduta di Assad, l’Organizzazione per il proibizione delle armi chimiche (OPCW), il cane di guardia delle Nazioni Unite sulle armi chimiche, ha dichiarato di aver contattato autorità siriane non identificate “al fine di sottolineare l’importanza fondamentale di garantire la sicurezza di tutti i materiali e le strutture relative alle armi chimiche”.
HTS ha risposto, dicendo: “Affermiamo chiaramente che non abbiamo intenzione o desiderio di usare armi chimiche o armi di distruzione di massa in nessuna circostanza. Non permetteremo l’uso di alcuna arma, qualunque essa sia, contro i civili o [permettere loro di] diventare uno strumento di vendetta o distruzione. Consideriamo l’uso di tali armi un crimine contro l’umanità”.
Il gruppo si sarebbe fatto un favore offrendosi di distruggere sotto supervisione internazionale le scorte di armi chimiche che cadono nelle sue mani e/o chiedendo all’OPCW di assistere nella ricerca di tali armi.