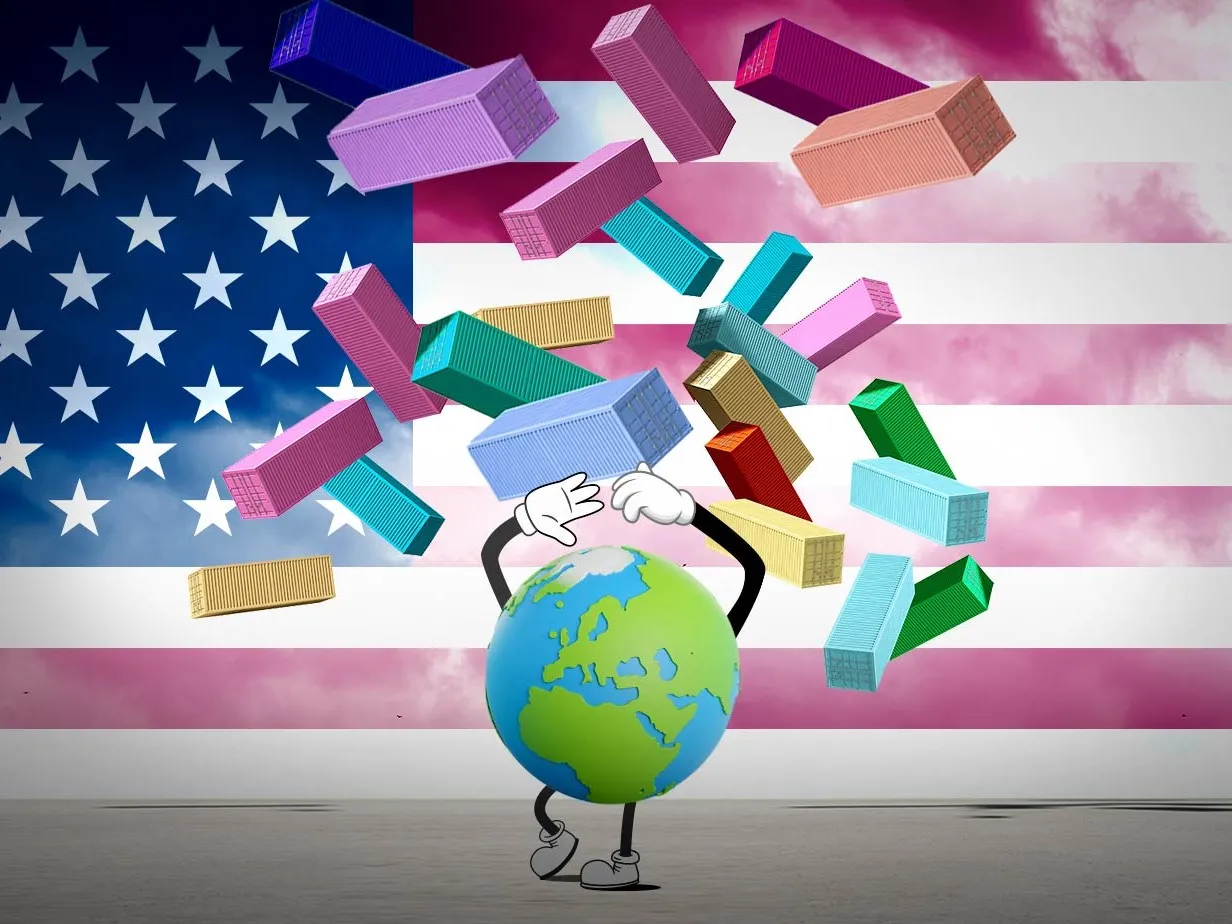Dopo un decennio di deglobalizzazione e geopolitica statunitense, la globalizzazione non è più a un bivio, ma si sta disfacendo. Più a lungo prevale questo tuffo, maggiori saranno i suoi costi.
Dopo dibattiti divisivi e rapporti contrastanti, il Presidente USA, Donald Trump, ha annunciato il suo piano commerciale: una tariffa di base del 10% su tutte le importazioni; “tarifa reciproca scontata” su “cattivi attori”: il 24% sul Giappone, il 20% sull’UE, rispettivamente; e una nuova tariffa del 34% sulla Cina.
Come previsto, è un piano protezionista che si basa su tariffe sia reciproche che universali, ma privo di una logica economica. Mentre i timori di una recessione aumentano e sono iniziate le proteste di massa negli Stati Uniti, la perdita di oltre 6 trilioni di dollari a Wall Street in soli due giorni è solo un preludio di ciò che verrà. Insieme all’imposizione della Cina su tutte le importazioni statunitensi di tariffe del 34%, Europa, Giappone e Corea del Sud, India e Brasile e il resto del mondo si stanno posizionando per contrastare le tariffe di Trump.
Mezzo decennio fa, le tariffe di Trump sulle importazioni dalla Cina rappresentavano 400 miliardi di dollari, o più del 90% del commercio interessato. Oggi, in quello che sembra essere il primo round di tariffe statunitensi con il Canada, il Messico e la Cina da soli potrebbero ammontare a più di 1,3 trilioni di dollari; cioè, oltre 3,5 volte più di mezzo decennio fa.
Ma con i nuovi round tariffari, i dazi internazionali più universali e le ritorsioni previste, che potrebbero rivelarsi più aggressive del previsto, molto, molto può accadere. Grazie a decenni di globalizzazione del dopoguerra, queste interdipendenze faticheranno a frammentarsi. Ma il processo di disfacimento è iniziato.
Addio globalizzazione
L’integrazione economica globale è spesso misurata dal commercio mondiale e dagli investimenti. L’ondata di globalizzazione del dopoguerra ha beneficiato principalmente le economie avanzate. Fu solo dopo il 1980 che alcuni paesi in via di sviluppo, guidati dalla Cina, sfondarono nei mercati mondiali di manufatti e servizi, attirando capitali stranieri.
Questa era di globalizzazione è stata eclissata dalla recessione globale del 2008. Man mano che la cooperazione del G20 è successivamente diminuita, sono diminuite anche le prospettive di crescita globale. Dopo il 2019, i brevi guadagni della tregua commerciale USA-Sino sono stati deragliati dalla pandemia di COVID-19 e dal terribile panorama economico internazionale. Come percentuale del PIL mondiale, il commercio mondiale durante il primo mandato del presidente Trump (“Trump 1.0”) è tornato al livello in cui era stato oltre 15 anni prima.
Dopo il primo round di guerre commerciali incentrate su Messico, Canada e Cina, la linea di tendenza sta scendendo rapidamente, più velocemente che nel 2018. Con l’inizio del secondo round – il lancio di ” tariffe reciproca” e/o ” tariffe universali” unilaterali – quella caduta si intensificherà e probabilmente aumenterà la crescente inflazione e la stagnazione della crescita; un mix corrosivo di stagflazione.
Ma disaggrega questi totali e ci sono differenze. Quando le guerre tariffarie diventano internazionali, le economie commerciali, misurate dal commercio in percentuale del PIL, sono le prime sulla linea di fuoco. Le economie dell’area dell’euro sono i principali trader, ma poiché commerciano principalmente tra altri paesi europei, è il loro commercio transatlantico che è sotto tiro.
Il Giappone ha beneficiato di Trump 1.0, che ha colpito principalmente la Cina. Ma poiché Tokyo non è immune da una guerra tariffaria internazionale, la discesa è iniziata. Dal 2008, Pechino ha spostato il suo modello di crescita dalle esportazioni e dagli investimenti verso il consumo e l’innovazione. Di conseguenza, il rapporto commerciale della Cina è costantemente diminuito da oltre il 60% al 37% del PIL, o il livello raggiunto per la prima volta intorno al 2000.
Negli Stati Uniti, il rapporto commerciale è stato relativamente più basso, intorno al 20%-25%. In passato, Washington considerava la cooperazione multilaterale internazionale troppo importante per rischiare. Ma quei tempi sono ormai finiti.
Investimenti mondiali a rischio
Prima della crisi globale del 2008, gli investimenti mondiali sono saliti a quasi 2 trilioni di dollari, con investimenti diretti esteri (IDE), che sono saliti al 5,3% del PIL mondiale, misurati dagli afflussi netti in percentuale del PIL. A seguito della grave recessione del 2008, il rapporto IDE si è più che dimezzato al 2,4%. Nel 2017, i fondamenti sono stati allineati per la ripresa globale. Tuttavia, l’auspicato rimbalzo degli investimenti mondiali è fallito, a causa delle guerre tariffarie di Trump 1.0. Nel 2020, il rapporto FDI era precipitato all’1,4%; un livello raggiunto per la prima volta 30 anni fa.
Da allora, questo fallimento è stato aggravato dalla depressione del coronavirus, dalla guerra per procura guidata dagli Stati Uniti/NATO contro la Russia in Ucraina e dalla guerra per procura armata e finanziata dagli Stati Uniti di Israele contro Gaza, per non parlare di una serie di nuove Guerre Fredde. Con la fine di Trump 1.0, il rapporto FDI è tornato al 2,4%. L’aspettativa era che l’amministrazione Biden avrebbe invertito la maggior parte delle tariffe ingiustificate. Invece, non solo ha cooptato le tariffe di Trump, ma le ha ampliate. Quindi, il rapporto è precipitato ad appena lo 0,7%, un livello che gli investimenti mondiali avevano raggiunto per la prima volta nel 1981, ovvero oltre 44 anni fa.
Ma anche qui ci sono differenze intriganti tra le economie. In Europa, gli investimenti esteri, misurati dagli afflussi netti (% del PIL), sono stati a lungo volatili. Ma sono finiti i giorni di gloria della globalizzazione, quando il rapporto era ancora del 10%, o anche la metà degli anni 2010, prima della Brexit, della pandemia e delle guerre, quando si aggirava intorno al 7%. Se Trump 1.0 lo ha fatto precipitare al rosso, Trump 2.0 inizia in un momento storico in cui è -2,2%.
In Cina, il rapporto IDE ha avuto il suo massimo nel 1994, quando ha superato il 6,2%. Grazie alla pressione coercitiva degli Stati Uniti sugli alleati e sulla geopolitica, ora si allea al di sotto dello 0,3%. Allo stesso modo, i benefici del Giappone durante Trump 1.0 sono ora diminuiti e il rapporto si sofferma a meno dello 0,5%.
Negli Stati Uniti, il rapporto era il più alto al 3,4% nel 2000, dopo la rivoluzione di Internet. Prima delle guerre commerciali di Trump 1.0, si aggirava ancora intorno al 2,5% nel 2015. Oggi è solo la metà di questo. Grazie agli attriti tariffari ingiustificati e ai conflitti geopolitici, gli afflussi netti sono ora a un livello raggiunto dagli Stati Uniti già alla fine degli anni ’80; cioè oltre quattro decenni fa.
Con Trump 2.0, i primi segni di un nuovo tuffo, molto più grave, stanno incombendo.
Costi globali della frammentazione
Essenzialmente, la deglobalizzazione riflette la ridutta dei flussi economici tra i paesi, sia misurati dal commercio mondiale che dagli investimenti. Fino a poco tempo fa, prevaleva ancora.
Durante Trump 1.0, la deglobalizzazione è seguita da scelte politiche, come le guerre tariffarie, e il declino delle forze strutturali. Quest’ultimo è stato utilizzato per stimolare una rapida integrazione delle economie fino al 2008, grazie al progresso tecnologico, alla riduzione dei costi di trasporto e all’offshoring di attività di valore tra i paesi.
Alcuni anni fa, ho esaminato questi costi che erano ancora in gran parte focalizzati sull’attrito commerciale USA-Cina. Con l’internazionalizzazione delle guerre commerciali statunitensi e l’ampliamento della loro portata, entrambe le quali sono ora la realtà, è probabile che le perdite concomitanti si rivelino molto più elevate, sia in termini di costi economici che umani.
La deglobalizzazione è una tattica dell’agenda di Trump, ma non della sua strategia. Il suo scopo finale è la frammentazione geoeconomica, a causa di “un’inversione politica dell’integrazione economica globale”, come la chiama il Fondo monetario internazionale (FMI). Come ha avvertito il vicedirettore del FMI Gita Gopinath, con le prospettive di crescita globale più deboli degli ultimi decenni, “non possiamo permetterci un’altra Guerra Fredda“.
Se l’amministrazione Biden ha cercato di “multilateralizzare” l’egemonia americana in collaborazione con gli alleati statunitensi, la Casa Bianca di Trump spera di “unilateralizzarla” dettando i termini al resto del mondo. Nel primo caso, le guerre commerciali hanno preso di mira principalmente la Cina e, in misura minore, alcune delle principali economie commerciali. In quest’ultimo caso, ci si aspetta che tutte le economie non statunitensi paghino tributo o rendite economiche a “America First”.
Nel processo, le economie del Sud del mondo più povero – molti dei quali il presidente Trump considera “paesi di merda” – pagheranno il conto relativamente più grande, sia in costi economici che di vite umane.
L’integrazione globale non è più a un bivio. La guerra fredda economica è già in corso. La globalizzazione si sta disfacendo.