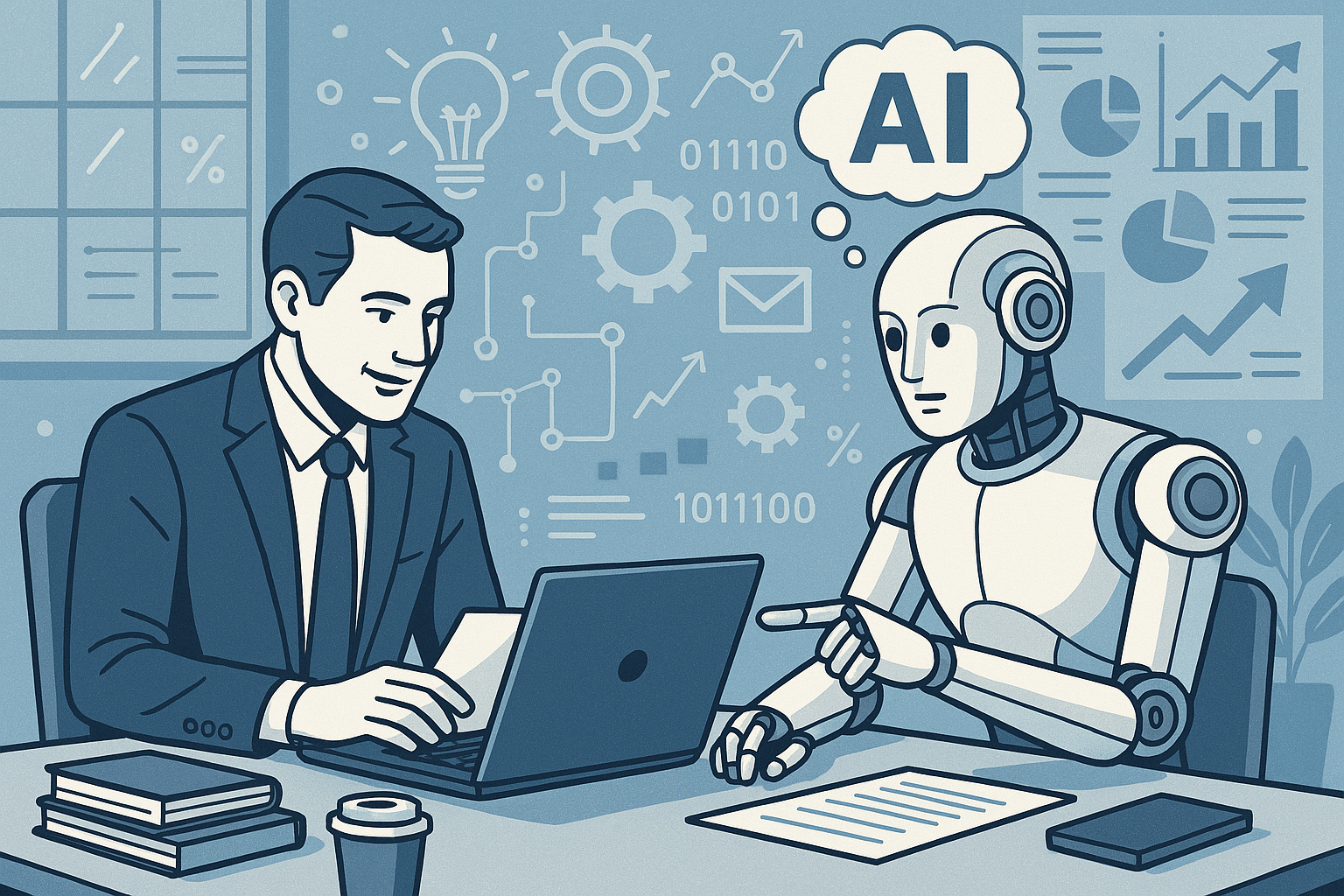La sfida non è più tenere il passo con le macchine, ma decidere che tipo di società vogliamo quando inevitabilmente si faranno avanti
Per due secoli, le rivoluzioni tecnologiche hanno promesso sia sconvolgimenti che rinnovamento. La Jenny che gira ha rotto il sistema della gilda, i trattori hanno spostato i lavoratori agricoli ma ne hanno nutriti altri milioni e i computer hanno scavato il lavoro d’ufficio mentre genavano intere industrie. Ogni ondata di innovazione ha suscitato ansia per la disoccupazione di massa, eppure, ogni volta, nuovi settori hanno assorbito gli sfollati.
L’intelligenza artificiale, tuttavia, è diversa. A differenza del telaio o del trattore, l’IA minaccia non solo il lavoro manuale, ma anche il lavoro cognitivo: redigere contratti, diagnosticare malattie, persino scrivere software. La domanda che i responsabili politici devono affrontare nel 2025 non è più se l’IA rimodellerà i mercati del lavoro, ma dove gli esseri umani troveranno ancora lavoro una volta che le macchine lavoreranno di concetto.
Il ritmo del cambiamento è straordinario. Il debutto di ChatGPT nel 2022 è stato seguito da Genie 3 di Google nel 2024, un sistema che ha permesso ai robot di navigare in ambienti del mondo reale. GPT-5, rilasciato nel 2025, ha spinto ulteriormente la frontiera del ragionamento. Questi non sono strumenti di nicchia. Sono tecnologie generiche che si diffondono a una velocità mai vista prima della rivoluzione industriale. Le proiezioni variano, ma puntano tutte nella stessa direzione: decine di milioni di posti di lavoro persi, centinaia di milioni potenzialmente automatizzati in tutto il mondo e licenziamenti negli Stati Uniti già ai massimi dagli anni della pandemia.
I sondaggi suggeriscono che quasi la metà delle aziende statunitensi prevede di tagliare il personale a causa dell’IA. L’Organizzazione internazionale del lavoro stima che il 14 per cento dei posti di lavoro a livello globale sia ad alto rischio di automazione, con un altro 32 per cento che probabilmente subirà importanti trasformazioni. Goldman Sachs ha messo la cifra di potenziale spostamento a 300 milioni di posti di lavoro in tutto il mondo. Questo sconvolgimento non è più ipotetico – è in corso.
La storia offre precedenti, ma non necessariamente conforto. I Luddisti che hanno distrutto i macchinari tessili si sono dimostrati in errore e la rivoluzione informatica ha eliminato i pool di dattilografia ma ha creato industrie completamente nuove. Eppure l’analogia di oggi vacilla. Quelle innovazioni precedenti hanno spostato il lavoro manuale aprendo nuove frontiere industriali: acciaio, automobili, informatica, ecc. Al contrario, l’IA automatizza la cognizione stessa. Se i trattori liberassero i braccianti agricoli per trasferirsi nelle fabbriche, dove andranno gli avvocati quando i contratti scrivono se stessi o i programmatori quando il software ripara il proprio codice? Questa volta, anche le classi professionali, a lungo considerate a prova di automazione, sono a rischio.
I governi si stanno arrampicando. Singapore sta versando denaro nella riqualificazione legata all’IA. L’UE sta pilotando ‘passaporti di competenze’ per aiutare i lavoratori a spostarsi in tutti i settori. Negli Stati Uniti, il reddito di base universale – una volta un’idea marginale – è entrato nel dibattito mainstream. Eppure questi sforzi sembrano macchie su una rottura. McKinsey stima che l’IA potrebbe aggiungere 4,4 trilioni di dollari di produttività annuale all’economia globale entro il 2040, ma quei guadagni non arriveranno in modo uniforme e non compenseranno quelli lasciati indietro. Se l’IA continua ad avanzare, non solo sostituirà impiegati e paralegali, ma anche radiologi, analisti e persino insegnanti, scuotendo le fondamenta della classe media.
Il contesto geopolitico aggiunge urgenza. La formazione di sistemi di intelligenza artificiale all’avanguardia richiede così tanto risorse che solo pochi Paesi e aziende possono competere. Il settore si è ristretto ai giganti americani e cinesi. Gli investimenti privati globali nell’IA hanno raggiunto i 67 miliardi di dollari nel 2024, con gli Stati Uniti che hanno conquistato circa la metà, mentre la Cina ha promesso più di 150 miliardi di dollari di spesa per l’IA entro il 2030.
Il settanta per cento degli studenti laureati in campi legati all’IA negli Stati Uniti sono nati all’estero e la Cina fornisce la porzione più ampia. I cittadini cinesi rappresentano circa il 30 per cento dei dottorati di intelligenza artificiale in America. Gli immigrati cinesi hanno fondato otto delle 48 più importanti aziende di intelligenza artificiale statunitensi e metà del team di “superintelligenza” di Meta è cinese. Eppure Washington sta stringendo la lotteria H-1B e castigando le università d’élite per fare affidamento su talenti stranieri – la “nascita dell’era ICE”. Proprio nel momento in cui l’America ha più bisogno di menti globali, le sta escludendo. L’ironia è lampante: un Paese terrorizzato di perdere la corsa all’IA contro la Cina sta mettendo da parte gli ingegneri e gli imprenditori cinesi che alimentano il suo vantaggio.
La ricerca sull’IA di frontiera oggi non è un campo aperto, ma un dominio strettamente recintato, limitato meno dal denaro che dalla scarsità di persone in grado di spingere il vantaggio in avanti. Il confronto è meno con la tecnologia di consumo che con i primi giorni della fisica nucleare, quando le scoperte dipendevano da una manciata di menti raggruppate in pochi laboratori.
Per le più grandi aziende tecnologiche, anche con miliardi da spendere, il pool di ricercatori più valorosi conta solo nelle basse centinaia – e, all’interno di ciò, ci sono forse alcune dozzine le cui intuizioni modellano in modo sproporzionato la direzione del campo.
Ma l’incertezza centrale non è solo chi guida la gara, è dove è diretta la gara. La letteratura sull’IA e la produttività rimane instabile non solo perché le prove sono sottili, ma perché non sappiamo ancora quale direzione prenderà l’IA stessa. Troverà la nuova elettricità, saturando l’economia o uno strumento esagerato – brillante in flash ma limitato? Fino a quando la traiettoria non sarà chiarita, ogni affermazione sicura sull’impatto a lungo termine dell’IA è più speculativa che scientifica.
Alcuni sostengono che gli esseri umani si sposteranno in aree in cui la fiducia, l’empatia e la presenza fisica sono indispensabili: assistenza agli anziani, ospitalità, servizi comunitari e artigianato, per esempio. Altri ripongono le loro speranze in industrie completamente nuove come la biologia sintetica o l’esplorazione spaziale. Ma tali alternative sono speculative e difficilmente assorbirebbero decine di milioni di professionisti sfollati a salari comparabili. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico avverte che è probabile che l’automazione basata sull’IA colpisca la classe media, influenzando in modo sproporzionato i lavori di medio livello che sostengono la stabilità sociale.
La possibilità più inquietante è che le società accetteranno la disoccupazione strutturale permanente, facendo affidamento sulla ridistribuzione piuttosto che sul lavoro. Ciò solleva questioni di identità e dignità: le società possono tenersi insieme quando il ruolo sociale del lavoro diminuisce? E più profondamente: cosa succede all’umanità quando l’atto stesso di pensare – un compito che una volta definiva la nostra specie – viene esternalizzato? Questo non è solo un problema economico, ma un enigma di civiltà. Cosa faranno le persone quando qualcun altro – o qualcos’altro – pensa per loro?
Il disagio pubblico riflette questa incertezza. Un recente sondaggio Pew ha rilevato che il 62% degli americani si aspetta che l’IA abbia un impatto importante sui posti di lavoro entro 20 anni, ma solo il 28% ritiene che migliorerà le opportunità di lavoro. In altre parole, la maggior parte delle persone vede arrivare l’automaziome, ma pochi si aspettano di trarne beneficio. Questa ansia non è fuori luogo – rispecchia la portata dei cambiamenti già in corso.
I responsabili politici stanno appena iniziando a cogliere la sfida. La ridistribuzione attraverso il reddito di base o le imposte negative sul reddito potrebbe attutire il colpo, ma è incerto se i contribuenti sosterranno tali programmi. La collaborazione uomo-IA, in cui le macchine aumentano piuttosto che sostituire i lavoratori, può rallentare l’erosione ma non fermarla. Ancora più radicale è ridefinire il ‘lavoro’ stesso, espandendo il riconoscimento alla cura, al volontariato e alle attività creative che l’IA non può replicare completamente. Ma questo richiede una rivisitazione del valore economico e dello status sociale che pochi governi sono disposti a intraprendere.
La posta in gioco non potrebbe essere più alta. L’IA sta già eliminando i posti di lavoro a un ritmo che non si vede dai tempi della Grande Depressione. Le analogie storiche sono confortanti ma fuorvianti: il motore a vapore, l’elettricità e i computer hanno rimodellato le economie, ma hanno preservato il primato umano nei domini cognitivi. Questa volta, le macchine stanno arrivando alla scrivania, non solo alla fabbrica.
La resa dei conti è inevitabile. Le società che si adattano possono navigare nella transizione costruendo reti di sicurezza, investendo nella complementarietà uomo-IA e coltivando nuove industrie. Coloro che falliscono rischiano la disoccupazione di massa e disordini politici di una scala non vista nella memoria d’uomo. La rivoluzione dell’IA ci lascia con una domanda più acuta: non solo quali posti di lavoro rimarranno, ma se la dignità del lavoro stesso può sopravvivere quando le macchine ci sopravanzeranno.
La sfida non è più tenere il passo con le macchine, ma decidere che tipo di società vogliamo quando inevitabilmente si faranno avanti.