Quali sfide attendono il Presidente? Sarà in grado di affrontarle? Intervista all’Ambasciatore Sergio Romano
In queste ore, la Presidenza Trump ha incassato il primo successo: è stata approvata dalla Camera la riforma fiscale che prevede 1500 miliari di tasse. Al contempo, è al vaglio del Congresso la capacità del Presidente di lanciare un attacco nucleare. Il Presidente degli Stati Uniti ha inoltre dato il via libera all’invio di una portaerei ed altre navi per un totale di 14 mila uomini nelle acque giapponesi di Okinawa. Qual’ è la strategia di Trump? Quale bilancio si può fare della Presidenza Trump, ad un anno dalla sua elezione? C’è il rischio di un’ esautorazione da parte del Congresso per incapacità?
Lo abbiamo chiesto all’ Ambasciatore Sergio Romano, diplomatico di lungo corso, avendo rappresentato l’ Italia alla NATO e a Mosca, oltreché docente e saggista, autore di una monografia, edita da Longanesi, intitolata “Trump e la fine dell’ American dream”, da pochi giorni nelle librerie.
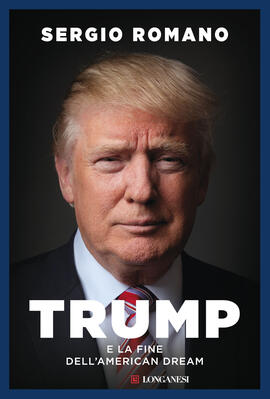
A ritorno dal suo viaggio in Asia, Donald Trump ha dichiarato: «L’ America è tornata e il suo futuro non potrebbe essere più radioso». Ha poi aggiunto: «il mondo ha visto un’ America forte e sicura». Ha ragione il Presidente oppure è iniziata la “fine dell’ American dream”?
Trump parla per se stesso e di se stesso. Quindi dipinge un Paese quale lui desidera venga recepito dal mondo. Ma, facendo un passo indietro, cosa significa ‘American Dream’? L’ America ha sempre avuto un altissimo concetto di sé: si ritiene privilegiata dalla Storia sin dal momento della sua fondazione e pensa di avere le caratteristiche di un ‘modello internazionale’, una Nazione creata da pellegrini che avevano un senso molto religioso della vita. Con il passare del tempo, si è addirittura considerata un modello politico-istituzionale esportabile in tutto il mondo. Questo è accaduto in gran parte con la Presidenza Wilson, durante la Prima Guerra Mondiale, quando gli Stati Uniti hanno dettato al mondo una ‘Carta Costituzionale’ della Società Internazionale che era, per l’ appunto, la ‘Società delle Nazioni’, e dopo la Seconda Guerra Mondiale quando si sono considerati il modello di democrazia che qualsiasi altro Paese del mondo dovrebbe adottare. Questo è il ‘valore americano’: l’ America si considera in qualche modo diversa, si considera portatrice di messaggi che dovrebbero aiutare il mondo a diventare migliore. Può ancora considerarsi portatrice di valori per un mondo destinato a diventare migliore se imita gli Stati Uniti nonostante siano il Paese che, nel corso degli ultimi due decenni, ha fatto due guerre inutili che poi ha perduto, si è lasciato alle spalle due guerre civili e con il suo modello economico-finanziario è responsabile della crisi del 2008? Io credo che sono queste le domande che occorrerebbe porre a Trump che, però, ragiona in un modo completamente diverso. Non è ispirato dal concetto che l’ America debba essere un modello per altri. Fondamentalmente Trump è un nazionalista egoista nel senso che pone l’ America al di sopra di qualsiasi altro Paese e ritiene che il compito di coloro che la governano debba essere quello di farne gli interessi. Nel concetto di ‘American dream’, l’ America aveva una vocazione internazionalista che, con Trump, non ha. Al contrario, ritiene di dover badare a se stessa, ai propri interessi.
Gli stessi argomenti che hanno condotto Trump alla vittoria.
Sì. Questi sono gli argomenti di cui si è servito durante la campagna elettorale e sono gli argomenti che sembrano effettivamente aver avuto una presa su quella parte della società americana che ritiene di aver perso per strada il sentimento della propria identità e della propria separatezza dal resto del mondo. Io credo che questo sia in gran parte dovuto agli effetti della globalizzazione o, quantomeno, a quegli effetti considerati negativi per sé da una parte della società americana.
Trump dice almeno il 5,5 bugie al giorno. A sostenerlo, un’ analisi pubblicata dal Washington Post, quotidiano fortemente avverso al Presidente. La tendenza a cambiare opinione in modo repentino è uno dei tratti dell’ attuale inquilino della Casa Bianca. Queste caratteristiche sono proprie di un businessman quale è Donald Trump oppure sono sempre più peculiari, nell’ era dei social media, dell’ uomo politico contemporaneo?
Non bisogna dimenticare che è in corso negli Stati Uniti una battaglia politica molto importante, accentrata sulla Presidenza di Trump e, addirittura, alimentata dal desiderio di una parte della società politica americana di sbarazzarsi di Trump con uno strumento, previsto dalla Costituzione, che è quello dell’ incriminazione cioè dell’ impeachment. Quindi le indagini del Washington Post non possono essere prese come oro colato, ma fanno parte di una polemica politica in cui il giornale non è un osservatore neutrale, ma, insieme ad altri giornali, è parte in causa. Stiamo assistendo ad una battaglia. Non c’è dubbio, però, che Trump è particolarmente spregiudicato, non avendo remore a contraddirsi, a cambiare opinione con grande naturalezza. Perché? Cosa si nasconde dietro questa fluidità? Probabilmente c’è il carattere di un uomo che si è formato con gli affari, che si è molto arricchito. Oltretutto, ha delle particolari caratteristiche quale uomo d’affari perché, mentre un uomo dell’ industria produce dei beni, Trump, nel corso della sua vita, ha venduto lusso e svago. Quindi si è rivolto ad un particolare mondo. Non bisogna, inoltre, dimenticare che non si è limitato soltanto a produrre beni e svago, ma ha anche venduto, in qualche modo, se stesso come personaggio esemplare: la sua attività di produttore televisivo e di protagonista di realityshows è un’ interessante dimostrazione della sua personalità. A questo punto, sì le bugie e le contraddizioni o le incoerenze diventano sempre più numerose.
Non è paradossale che Trump, un imprenditore che ha fatto affari anche grazie ai suoi rapporti con la politica, riesca a dipingersi come l’ ‘antisistema’?
Naturalmente c’è molto teatro, c’è molta messa in scena. Ma ci sono anche dei dati di fatto. Per ottenere la designazione alla sua candidatura, Trump ha dovuto battersi contro il ‘sistema’ del proprio partito. Non può essere considerato un repubblicano classico. E’ stato accettato dal suo partito, che, ovviamente, voleva tornare al potere e sconfiggere i democratici. Poi ha dovuto battere quella parte della società americana che si era identificata in una certa ‘ortodossia liberal – democratica’, di cui Barack Obama, è stato l’esempio nobile, e che prevedeva una società che si arricchisce di diritti. Naturalmente queste personalità politiche possono anche essere un po’ contraddittorie, non sempre all’ altezza dei propri ideali: ad esempio, i briefing che Hillary Clinton faceva nelle banche pagati in quel modo non mi sembra fossero ideali della migliore società democratica. Sicuramente per vincere Trump doveva battersi contro il ‘sistema’. Lui ha creduto, e i fatti sembrano dargli ragione, che doveva fare esattamente tutto il contrario di quello che aveva fatto Barack Obama.
Più volte, nel libro, fa riferimento ad una ‘guerra civile fredda’ tra un’ ‘America internazionalista’ ed un’ ‘America nazionalista ed isolazionista’. Quali conseguenze potrebbero derivare da tale conflitto?
Mi domando cosa accadrebbe se il partito dell’ impeachment vincesse. Tale partito dell’ impeachment è composto da personalità politiche prevalentemente democratiche, ma, forse, in qualche caso, anche repubblicane. Non c’è dubbio che Trump abbia molti ‘altarini scopribili’. C’è quindi un tasso di vulnerabilità abbastanza elevato. Nel corso delle ultime settimane, Trump ha cercato di rovesciare il tavolo dell’ indagine Muller, l’ ex direttore dell’ FBI che sta indagando sul ‘Russiagate’, mettendo su una sorta di movimento d’opinione che chiede di indagare anche su Hillary Clinton. Il fatto stesso che lui dia queste prove di nervosismo vuol dire che ha una certa vulnerabilità.
E’, in questi giorni, al vaglio del Congresso americano il potere del Presidente di lanciare un attacco nucleare, dopo le minacce che Trump ha rivolto a Pyongyang. Crede possibile un’ esautorazione del Presidente?
Dopo la morte di Kennedy, venne approvato un nuovo articolo della Costituzione, il XXVII, perché gli americani scoprirono che non esisteva un meccanismo costituzionale per la sostituzione del Presidente in caso di emergenza. In quell’ articolo, veniva stabilito che la carica sarebbe passata al Vicepresidente. Contemporaneamente, però, hanno fatto qualche cosa che non è stato, lì per lì, ben esaminato: hanno immaginato una situazione in cui il Presidente degli Stati Uniti desse dimostrazione di chiara incapacità ed inettitudine. Hanno cercato di porvi rimedio affidando al Vicepresidente, insieme ai componenti del vertice esecutivo, la responsabilità di comunicare al Senato tale incapacità presidenziale. Sappiamo che il Presidente è comandante in capo delle forze armate. Sappiamo anche che la dichiarazione di guerra non la fa il Presidente, ma il Congresso. E’ difficile dire cosa potrà succedere. Sono tutti sintomi di un disagio molto profondo perché non è immaginabile che gli avversari di Trump ignorino il consenso di cui Trump gode in una parte della società americana, ma sanno che qualora, un giorno, questo partito popolare di Trump avesse la sensazione che il suo leader viene trattato ingiustamente, non esiterebbe a scendere in piazza. Allora bisogna fornire delle prove che il Presidente è inadatto.
Riguardo al ‘Russiagate’, credendo, almeno pubblicamente, alle parole di Putin e riversando le responsabilità sugli ex responsabili dei servizi segreti, Trump si è attirato, qualche giorno fa, aspre critiche da parte della comunità dell’ intelligence. Da cosa nasce questa scarsa sintonia tra il Presidente e gli apparati dei servizi segreti, CIA in primis?
Innanzitutto la CIA ha una sua storia, una sua linea e probabilmente una sua politica. La CIA non è semplicemente uno strumento malleabile che fa quello che la Casa Bianca, in una determinata stagione politica, decide di fare. Come tutti i servizi di intelligence, deve avere un’ idea del mondo e di quelli che sono i suoi nemici nel mondo perché sono il bersaglio di cui occorre continuamente tener conto. La CIA non ha rinunciato a considerare la Russia un nemico. Oltretutto, ha bisogno di un nemico per giustificare anche i bilanci se non è in grado di convincere il Congresso e l’opinione pubblica che queste spese sono necessarie per la difesa della Nazione. La mia impressione è sempre stata che per la CIA quello è il nemico. Diciamo che non è ancora uscita dalla Guerra Fredda.
Ma è di nuovo Guerra Fredda tra Russia e Stati Uniti?
L’ elettrocardiogramma ha i suoi alti e bassi nel senso che non sempre vi sono stati periodi di freddo dopo la fine della Guerra Fredda. Se si guarda alle guerre balcaniche, tra la fine degli anni ’80 e l’ inizio degli anni ’90, si potrà notare che è stata fatta, anche da noi, la guerra alla Serbia che era un Paese che aveva sempre guardato alla Russia. Quando la guerra è finita, con il tentativo di Miloseviç di cacciare gli albanesi dal Kosovo, abbiamo dato l’ indipendenza al Kosovo. Ma davvero il Kosovo meritava l’ indipendenza? Ignoravamo che questa mossa occidentale, l’ indipendenza del Kosovo, sarebbe stata percepita da Mosca come un’ occupazione, come la creazione di un nuovo satellite? Questo per dare l’ idea di come a certi impulsi si continua ad obbedire.
Ritornando al ‘Russiagate’, che sta coinvolgendo anche affini al Presidente, ci sono gli estremi per un impeachment?
Non ho l’ impressione che ci siano questi estremi. Inoltre l’ impeachment non ha mai veramente funzionato perché è stato utilizzato in due casi (Jackson e Clinton) ed in entrambi è mancata la maggioranza dei due terzi del Senato necessaria per procedere. Non credo che oggi ce ne siano le condizioni. Tant’ è vero che la continua ricerca della ‘pistola fumante’ è la chiara indicazione del fatto che non hanno materiale su cui lavorare.
I dati economici però sembrano premiare il lavoro del Presidente: numeri da record per le borse e una forte diminuzione della disoccupazione.
Sicuramente i dati economici gli sono favorevoli. La cosa è ancora più buffa perché noi sappiamo che l’ economia va bene e il governo ne trae vantaggio sotto il profilo dell’ opinione pubblica, della percezione dell’ opinione pubblica. Ma c’è veramente un rapporto tra i due fenomeni?
E’ stata approvata, in queste ore, dalla Camera, con 227 voti a favore e 205 contrari, tutti i democratici e 13 repubblicani, la riforma fiscale che prevede il taglio delle tasse alle imprese e ai lavoratori per 1.500 miliardi di dollari. Si attende ora l’ approvazione da parte del Senato. Dopo il fallimento nel tentativo di smantellare l’ Obamacare, iniziano dunque i successi dell’ Amministrazione Trump?
Sì. Questa riforma fiscale è, tra l’altro, la ragione per cui, anche i senatori repubblicani che non amano Trump, hanno deciso di aspettare pazientemente perché, tutto sommato, è il solo uomo che possa dare ai repubblicani una riforma fiscale più o meno corrispondente a ciò che hanno promesso da molti anni agli elettori. Se riuscisse a condurla in porto, questo gli darebbe parecchio ossigeno. Il problema è che questa riforma comporta inevitabilmente un aumento del bilancio dello Stato: diminuiscono le entrate fiscali, ma non diminuiscono le esigenze, anche militari, dello Stato. Trump, come si è visto nel viaggio in Arabia Saudita, gioverà all’ industria militare ed è, tra l’ altro, aumentata la presenza dei militari nell’ Amministrazione. Vuole far risparmiare i suoi elettori, ma non farà risparmiare lo Stato. La cosa interessante è che gli Stati Uniti hanno bloccato il bilancio per legge. Questo vuol dire che si dovrebbe passare per il Senato per aumentare il tetto. A questo punto, faranno prima la riforma fiscale o prima aumenteranno il tetto? E’ un problema che dovranno comunque affrontare, cercando di negoziare che, però, non è l’ arte di Trump.
Questo suo temperamento preoccupa un po’ tutti, anche al di fuori dei confini statunitensi. In riferimento a quanto sta avvenendo nella penisola coreana, Trump riuscirà a gestire la crisi?
Se lei fosse il leader della Corea del Nord e avesse a sud, alla frontiera meridionale, un Paese protetto dagli Stati Uniti, con l’ installazione di un sistema antimissilistico che priva i suoi nemici di molte capacità offensive, senza contare il progetto di riunificazione che i nordcoreani non hanno mai abbandonato, qualche problema sicuramente ce l’ avrebbe. Le cose poi cambiano a seconda del carattere delle persone che sono incaricate di gestirle. Cosa c’è di nuovo, allora, in questa crisi? Di nuovo sostanzialmente niente perché le abbiamo sempre viste: volendo avere un deterrente nucleare, vecchia ambizione della Corea del Nord, ogni tanto Pyongyang deve fare delle sperimentazioni, contro cui gli Stati Uniti invocano trattati e vince lo spirito negoziale. Di veramente nuovo c’è il carattere dei due protagonisti e il fatto che Trump deve fare esattamente il contrario di quello che faceva Obama. E allora? Ma poi qual è l’ obiettivo? L’ eliminazione delle armi nucleari? C’è qualcuno veramente convinto che si possano eliminare le armi nucleari? Peraltro esiste il ‘Trattato di non proliferazione’ con cui il Club Nucleare ha cercato di preservare il monopolio delle armi atomiche, impedendo agli altri di entrare in possesso di quegli armamenti. C’è da sorprendersi se allora a qualcuno un trattato del genere non piace?
Riuscirà Trump a sviluppare un dialogo proficuo, anche in virtù delle sfide da affrontare, con la Cina?
Ho l’ impressione che Trump si sia infilato in un vicolo cieco. E’ chiaro che lui considera che la Cina costituisca una minaccia al potere economico americano. Ma se fosse solo questo, avrebbe dovuto sottoscrivere il TPP che aveva fatto Barack Obama perché quell’ accordo aveva creato un rapporto di convivenza economica profittevole per gli Stati Uniti e per tutti gli altri 11 Paesi che ne erano firmatari. Solo che la Cina non era compresa, era stata tagliata fuori da Barack Obama che aveva, in qualche modo, ridotto la possibilità che divenisse egemone in Asia. Invece Trump ha denunciato il TPP. Non essendoci più quel trattato, ha restituito alla Cina il diritto di fare una politica asiatica senza dover esser vincolata. Ma non si ha il diritto di chiedere la razionalità a Trump.
Riguardo al Medioriente, ha invece le idee chiare Trump?
Io credo vada a caccia di qualche successo. Soltanto non ne vedo le condizioni. Nel caso dell’ Arabia Saudita, grazie anche all’ aiuto del genero, ha puntato sul Regno. Ha fatto dunque una politica anti-iraniana. Siccome essere anti-iraniani piace anche ad Israele, può contare sul consenso di almeno due Paesi. Fare una politica anti-iraniana gli conviene veramente? Certo non conviene a noi.
E sull’ onda di questo ragionamento, ha decertificato il JCPOA, l’ accordo sul nucleare iraniano fortemente voluto da Obama.
Certamente. Poi si tenga presente che, in questo modo, ha fatto un investimento politico sull’ Arabia Saudita. Siamo sicuri che funzioni? Il Principe ereditario ha un padre forse affetto da ‘dementia’. Inoltre, ora molti principi sono stati collocati in una ‘prigione d’oro’ e molti arabisti della politica estera americana sono certamente preoccupati. Questo Principe ereditario si sta costruendo, dunque, una forte opposizione e nessuno sa quanto conti quell’ opposizione. E allora siamo sicuri che sia stata fatta la scelta giusta?
Il suo saggio si conclude con un monito all’ Europa. La Cancelliera tedesca Angela Merkel aveva parlato di “prendere in mano il proprio destino”. Al momento l’ Alleanza Atlantica lega l’ Europa agli Stati Uniti. E’ possibile un’ Europa senza NATO?
Lo spero ardentemente. Anzitutto qualche progresso in Europa si sta facendo. Io vedo dei segnali positivi. Inoltre è positivo il fatto che alcuni Paesi non siano d’accordo. Quanto più vedo restringersi il numero di Paesi disposti a fare un sacrificio di sovranità, tanto più ne sono confortato. Inoltre, non essendoci più l’ Inghilterra, se è meno evitabile che gli Stati Uniti perdano progressivamente la capacità di esercitare un ruolo egemone, soprattutto nel continente europeo, questo significa che si crea un vuoto. I vuoti sono terribilmente pericolosi. E allora quel vuoto va riempito e chi, se non l’ Europa, ha interesse a farlo?

